STILI COGNITIVI
Nel
1977 Robert J. Sternberg ha
formulato una delle ultime e più interessanti teorie sugli studi cognitivi con
relative ricadute nel processo d’insegnamento stesso.
Innanzitutto lo studioso ci fornisce
delle precise definizioni dei termini abilità, stile e strategia, che sono
diversi tra loro.
Con
abilità si intende
la capacità del soggetto di eseguire
determinati compiti, per esempio capacità di memoria, di creatività,
l’insieme delle abilità vengono incluse nel termine di intelligenza. Lo stile è il modo in cui queste abilità vengono utilizzate
da ogni singolo soggetto.
L’effetto
di maggior privilegio, in ambito educativo deriva dell’uguaglianza dello stile
cognitivo tra discente e insegnante. Il docente deve essere consapevole di questa importante asserzione, al fine di non giudicare un
allievo più o meno intelligente di un altro, semplicemente per il fatto di
possedere uno stile cognitivo piuttosto che un altro.
Per
delineare i principali
stili cognitivi, Sternberg conduce numerosi
studi, tra i quali quello della teoria
triarchica dell’intelligenza (studi del 1985 – 1988).
Secondo
questa teoria l’intelligenza umana
comprende tre aspetti relativi alla relazione esistente tra:
- Rapporto
intelligenza – mondo interno dell’individuo;
- Rapporto
intelligenza – esperienza individuale;
- Rapporto
intelligenza – mondo esterno.
Ognuna
delle tre relazioni chiama in causa diversi tipi di componenti.
Quindi dal primo rapporto, intelligenza – mondo
interiore, derivano:
TEORIA
TRIARCHICA

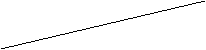
![]() DELLA MENTE
DELLA MENTE
![]()
![]()
![]() Intelligenza – Mondo interiore Intelligenza – Esperienza Intelligenza
– Mondo esterno
Intelligenza – Mondo interiore Intelligenza – Esperienza Intelligenza
– Mondo esterno
Metacomponenti
Automatismo Adattamento
Componente della
prestazione Novità Selezione
Acquisizione di conoscenza
Modellamento
Inoltre,
un ulteriore contributo fondamentale per la ricerca
degli stili cognitivi, Sternberg ce lo offre
delineando i tre tipi basilari dell’intelligenza, che sono:
- Intelligenza Analitica: la scuola tende
principalmente a favorirla, poiché è legata al pensiero astratto; essa consistente nella capacità di scomporre, confrontare, analizzare, esaminare i
dettagli, giudicare, valutare, spiegarsi il perché delle cose.
- Intelligenza Creativa: capacità di produrre il nuovo, di formare nuove combinazioni di idee, di affrontare la vita in modi diversi da
quelli consueti; questo secondo tipo di intelligenza comprendente l’intuizione, l’immaginazione, la
scoperta, il saper ipotizzare, il saper inventare.
- Intelligenza Pratica: abilità di sperimentare manualmente, di utilizzare gli strumenti,
di saper organizzare, realizzare, applicare progetti concreti.
Sternberg afferma che la correlazione tra queste
tre tipologie di intelligenza è più o meno bassa,
quindi una persona che eccede in un tipo non vuol dire che avrà gli stessi
risultati nelle altre due. L’autore ci tiene a precisare che l’intelligenza non è solo quella che ritroviamo nell’aula
scolastica, ma è nella vita reale, è intorno a noi.
Da
tutte queste ricerche, Sternberg, tra il 1988 e il
1994, giunge alla formulazione della Teoria
dell’autogoverno della mente, secondo la quale gli individui, in situazioni problematiche, siano esse delimitate all’ambito scolastico o presenti nella
vita quotidiana, si pongono secondo
particolari modalità che sono strettamente legate alle
strategie operative personali
ò
il modo personale e preferenziale di
ogni individuo di usare le abilità;
È
in questo ambito che compare lo stile cognitivo,
definito dallo stesso Sternberg
come
“tendenza costante e
stabile nel tempo a usare una determinata classe di
strategie” (R.J.
Sternberg, “Stili pensare”, 1997 ).
Partendo dalla metafora delle forme di governo,
l’autore classifica gli stili in base
alla loro funzione, alla forma, ai livelli, alla sfera ed alle propensioni o
preferenze.
Indi per cui abbiamo tredici stili, ordinati sotto cinque categorie:
- Funzioni:
a)
Legislativa
b)
Esecutiva
c)
Giudiziaria
- Forme:
- Monarchica (preferisce concentrarsi con il
massimo impegno su un obiettivo alla volta o su un’unica area di interesse;)
- Gerarchica (si dedica ad una pluralità di interessi o obiettivi ed è consapevole che non può
dedicarsi ad entrambi contemporaneamente. Per questo motivo riesce a gerarchizzarli secondo un ordine di priorità.)
- Oligarchica (attratto da numerosi interessi,
ma non riesce a collocarli secondo una giusta priorità. In questo caso è
basilare l’aiuto dell’insegnante al fine di analizzare con il ragazzo i
vari obiettivi che si è posto, cercando insieme di fissare delle priorità)
4.
Anarchica (è specifico degli
alunni che si dimostrano frenetici, iperattivi, che
passano da un obiettivo o un interesse all’altro senza mai portarne a termine
uno. Sono ostili alle regole, ma spesso possono giungere a soluzione di
problemi in maniera del tutto nuova e particolare, al
contrario di altre persone; se ben guidato e stimolato dall’insegnante,
l’alunno “anarchico” può mostrarsi particolarmente creativo.)
- Livelli:
a)
Globale
b)
Analitica
- Sfere:
a)
Interna
b)
Esterna
- Propensioni:
1)
Radicale (porta l’alunno ad
oltrepassare le regole e le procedure già date per giungere alla soluzione dei
problemi, optando per delle più originali soluzioni,
alternative nel modo di affrontare le questioni
2)
Conservatrice (I conservatori
manifestano una estenuante difesa delle procedure già
note, che in passato li hanno condotti a soluzioni soddisfacenti.)
Analizziamo
ora nel dettaglio le componenti di ogni categoria
della teoria dell’autogoverno mentale di Sternberg.
Per
quanto concerne le funzioni, abbiamo tre tipologie di stili:
-
le persone con uno stile
cognitivo legislativo sono prevalentemente creative, amano generare,
formulare, progettare idee,
progetti; preferiscono decidere in modo autonomo le procedure, le
regole e quindi sono ostili alle istruzioni fornite da altri;
-
coloro che mostrano
una forte propensione verso uno stile
esecutivo preferiscono agire dopo aver ricevuto istruzioni da terze
persone, eseguono ciò che gli viene richiesto;
-
i soggetti con stile
giudiziario privilegiano l’analisi attente, la
valutazione, il giudizio, il confronto di ciò che viene loro proposto.
Secondo
Sternberg la scuola
tende a privilegiare
e a premiare lo stile esecutivo:
l’insegnante impartisce le regole, le spiegazioni e poi assegna alla classe i
compiti da svolgere seguendo le sue indicazioni. Questo può far sì che studenti
con un diverso stile cognitivo, come ad esempio quello giudiziario o
legislativo, possano essere considerati poco intelligenti e non venire apprezzati per le proprie doti.
Sul
piano dei livelli Sternberg fa una distinzione tra le
persone che hanno una percezione globale delle cose, e quelle analitiche; questo punto risente dell’influenza delle ricerche
compiute da Witkin sulla dipendenza - indipendenza
dal campo.
I
soggetti globali notano la questione d’insieme e
tralasciano i dettagli, diversamente gli analitici ritengono fondamentali i
dettagli di una situazione e li esaminano approfonditamente, perdendo di vista
il quadro generale.
Anche
l’area della sfera è suddivisa in
due categorie composte dalle persone che preferiscono
il lavoro individuale, che sono introverse e poco propense alla
socializzazione, ovvero gli “interni”, e dagli “esterni” che sono estroversi, che amano il lavoro di grande e piccolo gruppo sia per giungere a delle
soluzioni soddisfacenti, sia per socializzare.
Sternberg fa un elenco di metodologie di insegnamento più consone allo
stile cognitivo favorito da un discente:
lo stile esecutivo è
facilitato nella normale spiegazione,
quello giudiziario è
aiutato nelle domande che promuovono il
ragionamento,
quello legislativo
predilige l’elaborazione dei progetti.
Quindi
nell’atto educativo, se l’insegnante favorisse un unico metodo di insegnamento, penalizzerebbe gli alunni con altri stili
cognitivi. Quindi il docente deve cercare di mediare, di combinare tutti i metodi
d’apprendimento, anche se il percorso è molto lungo e faticoso.